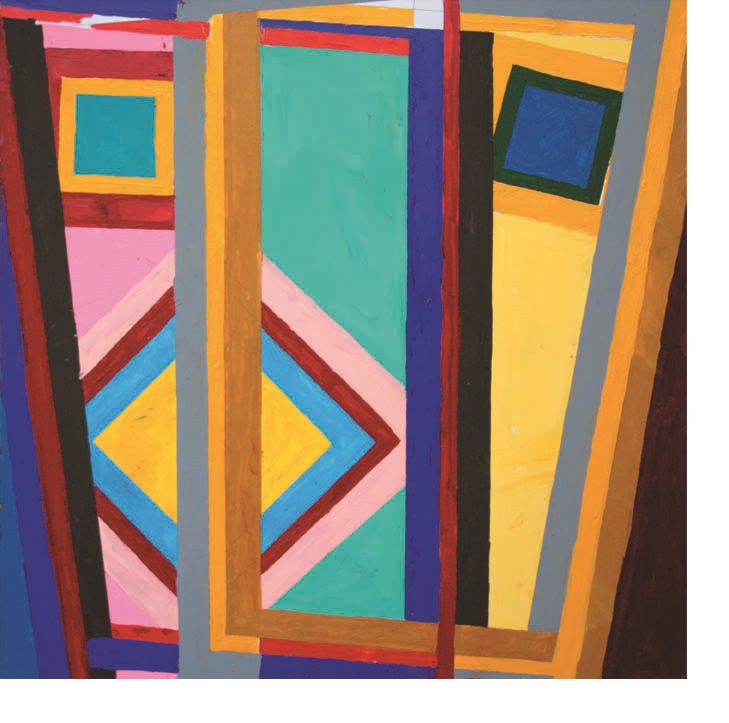Un giorno mia madre mi porta scuola. Avevo quattro anni. Un po’ come portare un novantenne sulla luna. Io non avevo fatto il nido, non c’era negli anni settanta il nido, credo. Quattro anni erano l’intera mia vita. Metà della quale passata per giunta da figlio unico. Ecco nella testa di un bambino di quattro anni le proporzioni sono queste: io sono al cento per cento della mia vita, due anni fa ero di mezz’età. Dice, ma tu sei un aristocratico, figurati se un bambino di quattro anni dice di mezza età! No, dice, quando ero piccolo. E se gli dici tu sei piccolo, quello risponde, anche un po’ grande però. E quindi io sono stato portato al mio primo giorno di scuola, come se mio nonno fosse stato spedito su Marte o in un nosocomio, poco importa. Come un clandestino che arriva in Europa.
Roma in settembre, io vedevo il marciapiede. Io pensavo di vedere il marciapiede perché ero piccolo. E invece no, io ancora adesso, che sono alto un metro e settantacinque, cammino guardando il marciapiede, il collo nelle scapole, tanto che se di traverso sul marciapiede c’è parcheggiata una moto, la vedo solo all’ultimissimo momento, un palo non appariscente invece no, quello lo prendo in fronte direttamente. E ricordo che avevo dei sandali rossi con le calzine, e ricordo anche l’autobus che abbiamo preso, con i bastoni di metallo nudo per reggersi e le sedie di plastichino color legno pino, con ancora il posto per il controllore, con le bucce dei lupini dove prima c’erano biglietti e cassa. Il 49 da Primavalle a Santa Maria del Riposo. E ricordo il sole e pure mia mamma aveva i sandali, che sbattevano forte contro il marciapiede perché eravamo in ritardo, e si camminava tanto, e una gonna verde e nera a scacchi, con delle filature di rosso, che si riempiva dei suoi passi mentre camminava veloce. E i pini di Piazza Carpegna, verdi, ricordo, e il brillio cromato di un parafango di una centoventiquattro beige e una piccola pozzanghera, di una pioggia di due giorni prima: il diciannove settembre millenovecentosettantotto aveva piovuto, evidentemente, perché c’era quella piccola pozzanghera residua e io, con i miei passetti sandalosi, mentre mia madre trottava in ritardo, dovetti compiere una mezza corsetta per aggirarla, la pozzanghera e restare pure al passo. Che dice, il mare di Libia, rischi di affogare, ma quella è solo l’ultima tappa e qualcuno l’aggira, fa la rotta balcanica, e arriva lo stesso, con una madre per mano.
Di mia madre che parlava e mi spiegava che la scuola, sai, è come un lavoro, che come lei andava a insegnare io sarei andato a studiare, che era una cosa da grandi e che poi, ah, che poi in quella scuola mi avrebbero parlato in tedesco. Che un giorno, tanto tempo prima, sarà stato l’anno prima, sarà stato un quarto della mia vita, un po’ come dire oggi (che ho quarantatre anni) un decennio fa, un giorno siamo andati a piazza Montecitorio, che c’era la Herder, la libreria tedesca e avevamo comprato un libro immenso, di un milione di pagine, il dizionario Loescher, Tedesco-Italiano; Italiano-Tedesco; che mia madre ha subito foderato con una copertina di plastica trasparente gialla. Che lasciava intravvedere sotto la copertina grigio scura, grigio chiara, con le scritte bianche e un fumetto. Tim und Struppi, che poi era Tin Tin, l’isola misteriosa, e mia madre cercava nel dizionario giallo-grigio le parole che non sapeva e poi scriveva nel fumetto, a matita, la traduzione. Che a me mi pareva un peccato, scriverci sopra al fumetto, che era uno dei primi fumetti della mia vita, mi pareva un peccato e quindi mi misi a cancellarle via quelle scritte, con la gomma bianca, Stadler, con il cartoncino azzurro intorno. Che poi mia madre però ovviamente se ne accorse e per educarmi (presumo) buttò il fumetto dalla finestra. Doveva essere un atto simbolico e definitivo, come buttare fuori la Grecia dall’Euro, ma io pensai che, insomma per quanto vuoi, un fumetto se casca dal secondo piano di una casa, sia pure con i soffitti alti, di quelli da cinque metri, di una fattoria degli anni quaranta rimasta intrappolata in città, beh sì che insomma, non se la doveva esser rotta la testa Tin Tin. E di soppiatto scesi dopo un po’ le scale di casa, marmetto dopo marmetto, fino al cotto del piano terra, in una luce ombra dell’androne scuro, eroicamente superai lo sprofondo di rampa buia che portava in cantina, accostai il portoncino di legno verde per non rimanere chiuso fuori, e costeggiai la casa per andare a recuperare il fumetto. Che non era poi mal messo, anzi stava talmente bene che avrebbe ancora meritato tutta la mia ammirazione, per cui: cancellai via definitivamente le traduzioni di mia madre.
Ecco quindi io sapevo il tedesco così: insegnato a tre anni, da una madre insegnante, che per capire un fumetto aveva comprato un dizionario enorme e nel fumetto scriveva a matita le traduzioni accanto alle parole che non conosceva.
2) E quella che fa? Mi manda alla scuola tedesca. All’asilo. Con la maestra tedesca. Frau Hug. Bionda con i capelli corti e un maglione di cotone all’uncinetto, a righe arancioni e bianche e marroni, orizzontali. E un mondo di rumore di fondo permanente, non riconoscibile, un rumore di sedie spostate e risate e pianti e separazioni del primo giorno di scuola. Io non piangevo. E comunque poi fu chiaro che Frau Hug bisognava starla a sentire, o meglio fare silenzio. E ci sedemmo tutti in cerchio, ognuno con la propria sedia, di legno vero stavolta, su gambe di metallo. Chi sa che m’ha detto Frau Hug o che avremo fatto, ricordo il telefono senza fili, dirsi all’orecchio una frase, quel che capivi, capivi, non potevi domandare, dovevi prenderla così come l’avevi capita e poi ridirla al vicino, e poi vedere che usciva alla fine, tipo una bambina iniziava dicendo oggi c’è il sole e, dopo venticinque giri nelle menti di bambini poliglotti, usciva ich habe Schokolade gegessen (ho mangiato cioccolata). E per questo c’era un motivo, che però scoprii dopo, c’era chi parlava soltanto tedesco, chi era perfettamente bilingue e chi parlava soltanto italiano, d’orecchio in orecchio, maglioni, sguardi, gesti, occhi. E così io per caso, divenni molto amico di Monica Calcagni e di Alessandro Bu. Giocavamo ai quattro cantoni, prima di capire che in realtà ci trovavamo più a nostro agio a parlarci ma pure a muoverci da italiani, a giocare appunto a quattro cantoni invece che a Voelkerball, perché tutti e tre avevamo in comune questo fatto, di avere entrambi i genitori italiani. E quindi e quindi, quando il mio vicino mi sussurrò all’orecchio e io non capii un accidente, m’inventai, di nuovo, ricordo il processo di elaborazione musicale dei suoni colti, un qualcosa di affine: quattro parole, tre pause, l’ultima parola lunga. E sussurrai a mia volta al vicino. Che forse era Eva, un’infelice ragazzina lentigginosa, la mia frase. E questa cosa devono averla fatta un po’ tutti, perché neanche la mia frase arrivò fino in fondo, all’onda dei restanti dieci cervelli di quattro anni, che ascoltavano e rendevano per quel che potevano. Clandestinamente educati a comunicare per forza.
Poi suonò la campanella. E dalle altre classi, dai corridoi, sentii per la prima volta quell’urlo liberatorio che lanciavano i grandi, di anni cinque, correndo in giardino: La Pause. La, articolo italiano; Pause, nome comune tedesco che significa intervallo. Urlavano proprio: La Pauseeeeeeeeeeee e correvano al campo da calcio, a prenotarlo per la loro classe, per i loro compagni, lo urlavano liberandosi di quella pressione, dalla costrizione di dover stare seduti o anche solo zitti o anche solo al chiuso a fare il telefono senza fili, scattavano al suono della campanella e urlavano, mediando istintivamente tra le culture: La Pauseeee!!!!! E il giardino era sterminato, c’era una zona di cespugli, in ombra, dove una volta abbiamo trovato un gattino, di quelli romani, non nobili, striato grigio e nero e gli avevano tagliato la coda, chi? I grandi. E bisogna riattaccargliela. Andiamo da Doris, che il padre è medico. In che lingua mai sarà stato detto tutto ciò?
Che io volevo giocare a nascondino, perché a me del calcio non è mai fregato niente, neanche da piccolo, ma a nascondino non ci voleva giocare nessuno e Luigi che aveva i capelli rossi, lunghi, fuligginosi ed era esile e aveva lentiggini sul naso affusolato e voleva giocare da solo. No, dico, da solo, e io lo guardavo e dicevo, io sono solo e tu sei solo, e non va bene, non va proprio bene, se tu non vuoi giocare con me. E lui però giocava a far correre un cavallo, entro la staccionata e le sue mani fingevano di avere un lasso, che visibilmente batteva nella polvere e schioccava ordini: sembrava anche divertirsi. E allora poi me ne sono andato dalle bambine e con Monica e Federica e forse pure Annamaria, abbiamo giocato ai quattro cantoni, sotto un tetto di lamiera, che forse era un patio, con delle colonne perfette, di metallo, per stare tutti a distanza e toccarsi per scambiarsi il posto. E la scuola aveva le serrande verdi, che si aprivano contro il sole restando chiuse, solo per fare entrare la penombra. E le mosche. E i bagni avevano le mattonelle gialle. E ovunque c’erano appesi disegni di bambini, ai muri, sui vetri, ovunque c’erano solo disegni di bambini, di classe in classe.
E i disegni erano quello che parlavamo. Molto di più di qualunque lingua. I disegni che facevamo in classe, e che poi venivano appesi. I disegni della scuola, del giardino, del dizionario, dei fumetti, della pozzanghera, dei baluginii cromati delle fiat centoventiquattro. Erano disegni e non avevano parole, il pino secolare della scuola era simbolo di tutto, oggi ne hanno anche fatto una maglietta. Ma, anche se mio padre faceva il pittore, io non mi sentivo bravo a disegnare. Ci sono cose così. Non sei bravo a disegnare. Una cosa che ti dicono sulla base degli scarabocchi, di quelli che fai quando non hai età. Un sole, una casa, un leone, i colori che si disfano e s’incrociano, poca pazienza per l’insieme, poca fortuna, colori che s’insabbiano senza venir puliti. Il marrone, l’acqua, gli acquarelli sporchi, i pennelli gonfi di croste. Ma mio padre era pittore, mio nonno dipingeva. E io non ero bravo. Il tedesco invece, ah il tedesco, quello lo sapevo. Un dato di fatto, un talento. Che mi veniva diagnosticato addosso sempre dalla stessa coppia di genitori, quelli del dizionario per tradurre un fumetto. E così da sempre mi porto queste due cose, il talento per le lingue e il non talento per il disegno.
3) Piove. Ho una scarpa bucata. La suola si è consumata e proprio a centro pianta ha deciso di collassarmi in fradiciume sul calzino. Sono a Bruxelles. Passeggio lungo una piazza. Ho preso un panino. Ricapitolando, sono un emigrante. Ho una madre da emigrante che tutti i giorni mi telefona. Ho un lavoro da emigrante, che m’impone l’impinguinamento da ufficio, con scarpe troppo andate, per una passeggiata in pausa pranzo e ho un panino. Il ventotto marzo duemilasedici. Rispetto ai miei predecessori ho qualche vantaggio: Mia madre se n’è rimasta in Italia e non mi manda derrate alimentari. Parlo il tedesco e il francese, ho un profilo professionale decente, una laurea in lingue, un lavoro che si è sviluppato ed è considerato privilegiato da tutti quegli italiani che l’accesso al lavoro me lo hanno sempre negato.
“Perché sa, fa uno, lei saprà anche parlare le lingue (e tu non me lo sai neanche verificare, se io le lingue le so parlare o no), ma noi abbiamo bisogno di un commerciale dalla forte personalità, un leader vero, per aggredire il mercato tedesco, uno che se lo mangi il mercato, con esperienza internazionale consolidata.”
E invece molto più prosaicamente ero finito a lavorare a Disneyland. Parlavo quattro lingue. E anche se conoscerne le letterature era assolutamente inutile (se non controproducente), comunque mi pagavano duemilioni al mese. Che poi era senz’altro lo stipendio che avrebbero pagato al supervenditore con esperienza internazionale, che avrebbero voluto assumere in Italia.
E io ho un buco nella scarpa e piove. E c’è la crisi greca.
Questo è stato sempre il mio problema, in Italia. Mi mancava sempre qualcosa. Una volta era l’esperienza, la volta dopo guadagnavo troppo. E così andavo avanti, da Disneyland a un call center, da un call center a venditore, da venditore a manager, da manager a dirigente. Sempre all’estero, Olanda, Francia, Germania e Belgio. Mi sono accorto che la cosa stava diventando definitiva, quando questi personaggi hanno incominciato a invidiarmi. Dopo avermi sbarrato la strada per anni, hanno iniziato a trattarmi con deferenza. Beato te, dicevano, che vivi in un Paese civile. Che non hai i contratti a progetto, che non hai i Voucher (ma lo sai te, che vivi nel Paese dei balocchi, cos’è un Voucher?).
E io mi mangio un panino, sul marciapiede, piove, ho un buco nella scarpa e guardo le case, in lontananza, una chiazza di giallo, spacca il grigio, sul bianco bambagia, s’incendia per trasparenze su tra le scintille delle nuvole. E penso a Schaeuble. Porca troia.
La Grecia non riesce a rimborsare i debiti e quello la vuole escludere dall’Europa.
La Merkel ha detto, che se Plutone non paga i propri debiti, lo esclude dal sistema solare.
E io sono in Belgio. In territorio neutrale, per così dire. A guardare la Germania e l’Italia e la Grecia. A guardare l’Europa, dal buco della mia scarpa.
L’Italia mi ha obbligato a diventare europeo a forza di calci in culo. Che se parli le lingue ti danno per partente. Parti, ti dicono, parti, beato te che puoi, che aspetti? L’Europa delle opportunità. L’estero manna. E restaci. Fatti sentire quando torni. Chiama la mamma. Ricordati di chi t’ha voluto bene.
L’acqua nel calzino sciacqua, cioè produce rumore, ciak, ciak, sciacqua appunto, ed è pure fredda. Forse dovrei decidermi a comprare per ottocento neuri delle scarpe italiane, qui a Bruxelles, senza pensare, che ah, la prossima volta che torno in Italia mi compro le scarpe nuove. E’ che uno si sente italiano se quando torna dall’Italia ha le scarpe nuove e non le ha pagate il prezzo belga.
4) Ecco ora piove decisamente troppo, mi salvo in metropolitana. La Pauseeee penso e mi verrebbe da gridare, giù per il tunnel come in un enorme sassofono, adesso posso prendere la metro e andare all’aeroporto e prendere un aereo e andare a casa a comprarmi le scarpe. E non è detto che non lo faccia, ma sono seduto sulle sedie grigie e mi guardo la mia scarpa bucata e penso che proprio mi fermerei ora, che è proprio necessario, togliersi la scarpa, strizzare il calzino, prendere un aereo e andarmene. E c’è una vecchia con gli occhi azzurri che mi guarda, e c’è una ragazza, anche lei con gli occhi azzurri, che ha le cuffie nelle orecchie. E c’è un tizio con una scatola, legata con lo spago, ad un carrellino per le valigie, di quelli che giravano prima che le valigie avessero le rotelle. E c’è una mamma con la faccia da mamma, un bambino con la faccia belga e milioni di persone con lo sguardo fisso sul cellulare e c’è pure uno che legge e uno che legge persino un giornale, che c’è stato l’incidente, in Spagna, di quell’autobus che portava studenti Erasmus, da un capo all’altro dell’Europa e che poteva anche essere il mio di autobus, vent’anni fa, che io ero messo lì e parlavo le lingue e l’Erasmus l’ho fatto anche io, anche se non in Spagna ma a Monaco. E sono stanco e ho il calzino bagnato da strizzare e respiro per quello che il naso lascia passare, che sento un sapore rasposo in bocca come di malattia. E prendo il fazzoletto bianco in tasca, un fazzoletto di stoffa, che sono uno degli ultimi ad usarli i fazzoletti di stoffa, che mi ricordano Pasqua, perché io da piccolo a Pasqua ero sempre malato e i fazzoletti erano talmente fradici da non servire più, fradici come il calzino, di raffreddore e febbre. E mia madre non faceva a tempo a lavarli, ma quand’ero piccolo i fazzoletti di carta dopo un po’ bruciavano il naso e lo facevano diventare rosso. E poi grattavano il bordo delle narici. E così mentre penso al bordo delle narici, mentre penso al piede bagnato, alla scarpa bucata, al calzino da strizzare in pubblico, così nella metro, come atto di ribellione, mentre penso al mio destino di emigrante europeo che s’è delineato fin da piccolo, mentre sono una persona normale, solo priva di I-phone in cui affogare, mentre penso ai disegni dei bambini, mentre penso alla Pause, mentre penso alla Grecia e all’Italia, a Schaeuble e a Plutone, alla coda di clandestini in viaggio come me, con scarpe più bucate delle mie sul mare di Libia o per la rotta balcanica e mentre sono Bruxelles, proprio in questo momento, mi pare ma non ne sono certo, credo, niente, ecco: temo proprio di essere morto.
Soffiato semplicemente via dalla vita in un vagone qualunque della metro di Bruxelles.
E malgrado tutto, tutto questo, ha un senso perché dal tubo della metropolitana, esce un fumo nero nero dell’esplosione nel cielo, che alla fine s’è fatto azzurro persino a Bruxelles, il ventidue marzo duemilasedici. E questo fumo nero nero di anime soffiate via, forma aleggiando la scritta “ceci n’est pas une pipe.”